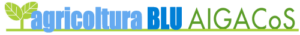Nel leggere i numeri della diffusione della semina su sodo nel mondo e poi confrontarli con quelli italiani, è inevitabile provare un certo scoramento. 125 milioni di ettari in tutto il mondo, di cui 25,3 milioni negli Usa, 23,6 in Brasile, 18,3 in Argentina e 12,5 in Canada, contro i circa 60mila stimati nel nostro Paese.
Certo, in Italia ha sicuramente preso più piede la minima lavorazione, ma nell’ambito del convegno organizzato a Villafranca di Verona (presso l’azienda agricola Le Fornaci di Pietro Spellini), da Confagricoltura Veneto e Confagricoltura Lombardia in collaborazione con Aigacos (Associazione italiana per la gestione agronomica e conservativa del suolo) la minima lavorazione non è stata praticamente mai presa in considerazione. Anche perché il protagonista della giornata rispondeva al nome di Carlos Crovetto Lamarca, agricoltore, presidente della Sociedad de Conservación de Suelos de Chile e assoluto pioniere della non lavorazione dall’America Latina in poi. Da oltre 30 anni Crovetto bandisce nella sua azienda a Chequen, in Cile, l’uso dell’aratro (praticamente demonizzato dall’esperto cileno) e di qualsiasi altra attrezzatura agricola per la lavorazione del terreno. La “Cero Labranza”, ossia Lavorazione Zero o no tillage, è come un Vangelo per Crovetto, che ebbe la prima intuizione alla fine degli anni Sessanta (falciare l’erbaio e lasciarlo sul terreno) e dal 1978 pratica la semina diretta nell’azienda ereditata dal padre. «Non credo sia sostenibile produrre senza un maggior riguardo per il suolo – ha esordito Crovetto – e l’opportunità per migliorare il suolo è la semina diretta. L’uomo che ha capito questo concetto lascia, quindi, i residui colturali sul terreno».
Erosione
La convinzione di Crovetto nacque in particolare a seguito dei gravi problemi di erosione a cui andavano soggetti i terreni negli Usa e in Sudamerica in particolare. Le numerose diapositive presentate da Crovetto hanno chiaramente mostrato il degrado erosivo a cui erano arrivati certi suoli e come ci siano voluti anni per riportarli a condizioni di coltivabilità. Ma le proprie convinzioni Crovetto le ha anche circonstanziate in termini di fisica e chimica del terreno. «Un terreno mangia qualcosa come 2.500 kg di paglia in un anno, pari a 1.450 kg di carbonio che sequestriamo dall’aria per metterlo nel suolo. Il suolo infatti si nutre non solo con il concime, ma anche con il carbonio, proprio quello che oggi nell’aria dà fastidio. Inoltre, durante la decomposizione dei residui colturali sul terreno i batteri citofagi generano dei composti colloidali poliuronici che migliorano la struttura del suolo; le lavorazioni del suolo, invece, degradano proprio questi composti colloidali deputati al mantenimento della struttura del suolo. Anche l’erosione si porta via i colloidi e noi non possiamo più recuperarli, cioè possiamo solo apportare sostanza organica, ossia materiale umico. Quest’ultimo deriva dalla decomposizione della sostanza organica e include, tra gli altri, l’umina, che non è degradabile e in assenza di aratura può durare fino a 500 anni, mentre se si ara, dura solo 50 anni».
L’ultimo passaggio di Crovetto ha riguardato l’equilibrio tra l’ecosistema naturale e il contenuto di carbonio. «Con l’agricoltura di conservazione il carbonio che si libera nell’atmosfera per ossidazione è pari a quello che viene fissato dalle piante con la fotosintesi. Se in Italia i terreni hanno un contenuto medio di sostanza organica del 2% circa, questo è già un campanello d’allarme. Io ho ereditato suoli con lo 0,8% di sostanza organica e adesso, dopo 35 anni di semina diretta, ne hanno il 5-6%. La stessa cosa la si può fare in tutta Italia e in tutti i tipi di terreni. E poi non si può dimenticare il risparmio idrico che si ottiene con il no tillage, dato che le coperture riducono le perdite d’acqua per evaporazione».
Transizione
A riferire della situazione a livello nazionale ci ha pensato Vincenzo Tabaglio, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e segretario di Aigacos. «Effettivamente in Italia ci sono difficoltà applicative, di mentalità e operative – ha ammesso Tabaglio – altrimenti tutti sarebbero già passati all’agricoltura conservativa. Ma anche se l’aratro nell’accezione comune è ancora sinonimo di agricoltura, che fosse l’attrezzo meno soddisfacente per la preparazione dei terreni ai fini della produzione agricola lo si sosteneva già nel 1943 (“La follia dell’aratore” di Edward H. Faulkner)».
Arrivare a terreni con solo l’1% di sostanza organica significa aver apportato danni permanenti alla struttura del terreno e anche in Italia ci sono situazioni di questo tipo. Allora come intervenire? «Per fare agricoltura conservativa – ha proseguito Tabaglio – servono livelli superiori di imprenditorialità, conoscenza e scienza. Per esempio, le seminatrici da sodo oggi disponibili non sono tante, mentre ogni terreno richiede una seminatrice da sodo particolare». Commentando, infine, alcuni dati sperimentali, Tabaglio ha evidenziato che non sempre ci siano risposte univoche, anzi, spesso ci sono differenze tra stagione e stagione, tra le colture, tra le rese, tra i livelli di micotossine, insomma c’è eterogeneità. «Bisogna (quasi) sempre mettere in conto che serve un periodo di transizione tra il passaggio dall’agricoltura convenzionale a quella conservativa, in modo da riuscire a riorganizzare il sistema suolo. E alcuni terreni possono non consentire la non lavorazione. Di sicuro quella che ci guadagna con la non lavorazione è l’idrostabilità strutturale del terreno: dopo 3 anni di non lavorazione, infatti, risulta del 120% superiore rispetto alla media di campo (mentre con l’aratura è inferiore dell’80%). In altre parole, i terreni lavorati sono facilmente disgregabili dall’acqua piovana».
da Terra e Vita
Francesco Bartolozzi